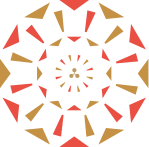«Ma la televisione ha detto che il nuovo anno / porterà una trasformazione, e tutti quanti stiamo già aspettando». Stavolta l’ironia di Lucio Dalla ne L’anno che verrà non è più soltanto ironia. Il mondo è davvero percorso da fremiti di cambiamento. Il prosieguo ci dirà se si tratta solo di sfarfallii sul monitor o di vere e proprie scosse di terremoto. In questi due mesi di blocco le analisi e le riflessioni sulla pandemia in corso si sono sprecate. Ciascuno a partire dal suo osservatorio particolare: scientifico, filosofico, economico, sociologico, politico, teologico, pastorale. Un coro a volte molto utile, altre volte assordante e anche un po’ cacofonico. Ora, aggiungere altri discorsi – dopo questa premessa – parrebbe una contraddizione. Eppure lo dobbiamo fare. Perché la formazione della coscienza non è fra gli ultimi compiti e fra le urgenze meno stringenti di questo momento. Dobbiamo chiederci cosa sta dicendo (alla Chiesa e all’umanità) questo segno del tempo che è il coronavirus. è ovvio che le emergenze sono molte: da quella sanitaria (la più impellente), a quella economica, a quella (non ultima) pastorale, legata soprattutto alla ripresa delle celebrazioni delle Messe e al riavvio di una normale vita ecclesiale. Ma anche la formazione di una coscienza cristiana dentro la storia concreta ha la sua urgenza. Nelle due precedenti schede abbiamo analizzato alcuni aspetti riferiti rispettivamente al «fare» e all’«essere» della Chiesa. In questa terza scheda proviamo a mettere a fuoco alcune dimensioni più laiche e secolari. Dal punto di vista ovviamente non dei diversi saperi umani – che hanno la loro specifica competenza – ma dei possibili riflessi sulla coscienza cristiana, illuminata dalla Dottrina sociale della Chiesa (DSC). Partiamo dagli aspetti più problematici (economia e politica), per arrivare ad altri più fluidi e anche promettenti (scienza/tecnica, comunicazione, ambiente).
a cura di don ANGELO RIVA
Liberisti o statalisti
Quello economico è l’interrogativo più complesso: come si ridisegneranno gli equilibri del sistema economico post-virus? Ovviamente nessuno lo sa. Dalla grande depressione del 1929 – frequentemente evocata come precedente storico di quanto sta accadendo oggi – saltò fuori lo Stato sociale e la correzione socialdemocratica (il cosiddetto «lib-lab») del liberismo economico puro della prima rivoluzione industriale. Cosa ne verrà dall’infarto economico del 2020? Chiaramente tutti i grandi players mondiali (Stati Uniti e Cina; più staccata la Russia; latitante invece l’Unione Europea) si stanno riposizionando ricercando il maggior vantaggio competitivo possibile. Il vento liberista soffia ancora molto forte in economia (vedi il turbo-capitalismo cinese), anche se la democrazia economica liberale sembra oggi accompagnarsi più volentieri a robuste dosi di autoritarismo (Cina; la Russia di Putin; in fondo è il sogno dello stesso Trump) che non alla democrazia politica (vedi punto seguente). Viceversa, però, il coronavirus, che ha infartuato il sistema liberista, sembra invocare a gran voce più statalismo in economia: perché solo lo Stato può in questo momento pompare liquidità negli stantuffi esausti dell’impresa privata (oltre che, ovviamente, dello Stato sociale). Ci attende allora una nuova stagione di statalismo economico (che vuol dire nazionalizzazioni, più servizi pubblici, quindi più tasse…)? Non a caso in Italia si parla di riesumare il vecchio IRI, che finanziò col denaro pubblico la ricostruzione post-bellica e quindi il miracolo economico italiano. E non a caso, per contrappunto, un vecchio falco liberista come il tedesco Schaeuble si è sentito in dovere di precisare che lo Stato può mettere soldi, ma sono le imprese a creare lavoro e sviluppo. Insomma, il coronavirus sembra disegnare, sotto l’aspetto economico, una nuova fase del rapporto fra liberisti e statalisti. Sotto altro profilo pare certa la necessità di rimodulare i dinamismi della globalizzazione: informatica, commerciale, finanziaria (che aveva già preso una sonora sberla con la crisi del 2008), dei popoli. Si è proceduto a una velocità troppo vertiginosa, bisogna trovare un profilo più «slow», nel senso di più umano, più valoriale, più relazionale. In questa direzione potrebbe trovare un senso plausibile anche la «decrescita felice». «Sviluppo sostenibile» e «glocale» sono bei termini, ma bisogna dargli un contenuto. I punti fermi della DSC restano la centralità della persona e della relazione, la visione solidale (principio di fraternità) e sussidiaria, l’economia civile (libero mercato, intervento statale, terzo settore), la giustizia sociale (contro l’economia dello scarto).
Globalisti o sovranisti?
L’ambito economico richiama subito quello politico, benché sempre più eterodiretto dall’economia (un tempo era la politica a guidare l’economia, oggi accade l’inverso). Qui c’è chi dice che il coronavirus favorirà una maggiore internazionalizzazione della politica, perché abbiamo capito che i fenomeni attuali sono globali, inter-connessi e trans-nazionali, e che quindi non possono essere affrontati in ordine sparso dai vari Stati sovrani. Quello di un’autorità capace di una governance mondiale rappresenta in effetti un’antica aspirazione della DSC, fin dalla Pacem in terris di Giovanni XXIII, e sta scritta, per così dire, nel suo stesso genoma «cattolico» (universale). Purché, però, venga debitamente intesa: e cioè secondo il principio di sussidiarietà, e non nel senso di un cosmopolitismo
neutro che azzera e fagocita le identità nazionali e culturali; e nemmeno nel senso di un pensiero unico globale iper-liberista e omologante, come spesso ha funzionato l’ONU negli ultimi anni. Viceversa, secondo altri, il coronavirus porterà acqua al mulino dei diversi nazionalismi e sovranismi, visto che è stata la troppa apertura, e la fluidità delle connessioni globali, la causa della pandemia. «Immunizzarsi dallo straniero», quindi – brutto, concorrente, invadente e adesso pure contagioso (fatto salvo il fare affari, beninteso) – potrebbe diventare il mantra della futura politica sovranista. Futura, peraltro, fino a un certo punto, visto che il verbo sovranista si va diffondendo a velocità supersonica (Trump, Bolsonaro, Putin, Erdogan, Orbàn, il gruppo di Visegrad…), proprio sfruttando le smagliature della classe dirigente globalista (le famose «élites»), la rabbia dei nuovi poveri (l’ex classe media impoverita) e la voce del disagio sociale che la sinistra liberal-borghese (dalla Clinton a Macron al PD di casa nostra) ormai non sa più ascoltare. Il Covid19, insomma, rischia di rendere ancora più frontale lo scontro fra globalisti e sovranisti, che ha reinterpretato, pur senza annullarla del tutto, la vecchia polarità destra/sinistra. Uno scontro che si ripresenta a più livelli: non solo mondiale, ma anche europeo e regionale. L’Unione Europea, per es., è a un bivio cruciale: o si rilancia su basi autenticamente solidali e sussidiarie, oppure il coronavirus (dopo l’ignobile gestione – quanto a cinismo e indifferenza – della questione migranti) sarà la sua pietra tombale. Lo stesso si dica da noi del rapporto Stato/Regioni: ci sono equilibri da ritrovare fra solidarietà e sussidiarietà, emblematicamente nel campo della politica sanitaria. Per la DSC sono parimenti inaccettabili sia il centralismo statale (che difetta di sussidiarietà), sia il regionalismo fai-da-te (che difetta di solidarietà).
Scienza, media, green
Ci sono poi una serie di ambiti che possiamo definire fluidi e promettenti, nel senso che il coronavirus ne ha svelato da una parte la debolezza (da cui potrebbe derivare un salutare bagno di umiltà), ma dall’altra parte ne ha rilanciato con forza l’importanza e la preziosità. Partiamo dalla scienza. La scienza – con il suo gemello operativo: la tecnica – si è dimostrata in questi giorni nuda. Si è sentito dire: «possibile che nel XXI secolo succedano ancora pandemie da medioevo? Prima non prevenute e poi non controllate?». è vero. Se mai la scienza e la tecnica avessero sviluppato un mito di onnipotenza, una pretesa di controllabilità assoluta sulla natura (la tecnocrazia come avveramento dell’antico sogno di Prometeo), alla vecchia natura è bastato un «ruttino» per mandarci a dire che, se vuole, comanda ancora lei. Che noi, in fondo, siamo solo pulviscolo e polvere. Che basta uno sputo di materiale biologico parassitario, sfuggito alla normale catena della causalità evolutiva, e neanche capace di esistenza autonoma (vive solo colonizzando una cellula ospitante, a prezzo ovviamente di decostruirne la funzionalità normale), per metterci tutti col sedere per terra. Allo stesso tempo, però, pur nella loro asserita fragilità, scienza e tecnica ci sono apparse in tutta la loro necessità. L’ancora a cui aggrapparsi, se non sul piano
delle motivazioni (per queste, serve altro…), almeno sul piano delle operazioni. L’unica risorsa operativa – benché ancora al momento ultimamente inefficace – che potevamo mettere in campo. Grazie, allora, a virologi, epidemiologi, micro-biologi, immunologi, statistici, rianimatori, intensivisti e così via. Sulla scienza e sulla tecnica – depurate da illusioni prometeiche – bisognerà in futuro sempre più puntare, investendo risorse ed energie. E speriamo che un vaccino arrivi presto. Discorso simile può essere fatto per i mezzi di comunicazione sociale, specie quelli nuovi. Tante volte, in passato, abbiamo inveito sulla loro pericolosità sociale (dai «hikikomori» giapponesi ai rischi del bullismo digitale e della pedopornografia) e sul loro contenuto spersonalizzante e anti-umanistico (ricordo la critica feroce di Umberto Eco). Più volte abbiamo rimarcato la distanza fra il digitale e il reale, e il rischio di confondere il primo con il secondo. E in effetti proprio i giorni dell’isolamento sociale ci hanno confermato che nulla potrà mai surrogare il contatto diretto, il faccia-a-faccia della presenza, della parola, della smorfia del volto e della profondità dello sguardo. Tuttavia, senza i «social media», quell’isolamento sarebbe stato molto più duro e pesante, forse insopportabile. I «social media» hanno permesso la sopravvivenza dei contatti, la custodia dei legami, la circolazione delle idee, il rafforzamento delle fragilità. A volte, magari, in forme eccessive e sguaiate, perfino alluvionali (tanto da doversi anche un po’ preservare…). Ma come avremmo fatto senza questi mezzi di resilienza sociale? Anche i nonni hanno imparato a smanettare su WhatsApp, e così non sono rimasti completamente privi della compagnia di figli e nipotini. Senza dire dell’utilizzo pastorale dei nuovi mezzi comunicativi. Ci si apre ora davanti una strada preziosa: quella di una sintesi più armonica e felice (più umana) fra relazioni reali e relazioni digitali. «On-life», ha detto qualcuno. Infine l’ambito ecologico e ambientalista. Ormai è chiara una connessione di fondo fra saccheggio umano dell’ambiente naturale e crisi epidemiologiche (ricorrenti nel XXI secolo). E proprio la dis-antropizzazione del lockdown è sembrata per un attimo restituirci un mondo più sano e pulito: dall’aria finalmente respirabile delle metropoli, all’acqua del Canal Grande ritornata limpida. Allo stesso tempo, però, ci siamo resi conto che una natura linda e pettinata non avrebbe molto senso senza l’uomo che ne rappresenta il vertice: come ha ironicamente commentato Aldo Grasso, «abbiamo ritrovato l’Eden ma abbiamo smarrito l’umanità». La strada per il futuro sembra quindi tracciata: ritrovare una vera armonia fra l’uomo e il creato, fatta di rispetto profondo al netto di sciocchi riduzionismi ecologisti. Ossia quel concetto di «ecologia integrale» che la DSC aveva già annunciato nel 1991 con la Centesimus annus di Giovanni Paolo II, e che la Laudato si’ di papa Francesco ha mirabilmente approfondito.